Black Arts Movement School Modality: appunti da una settimana milanese su coalizioni arcobaleno, archivi coloniali e eredità condivise
di Mackda Ghebremariam Tesfau'
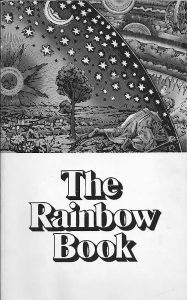
La settimana dal 22 al 26 maggio, presso il Mudec (Museo delle Culture) di Milano, si è tenuta la «Black Arts Movement School Modality», in presenza dell’ideatrice Romi Crawford. La scuola è stata creata con l’obbiettivo di facilitare un dialogo intergenerazionale tra l* protagonist* del Black Arts Movement e artist*, educator* e teoric* attiv* oggi. Nella sua versione milanese, la scuola ha ospitato più sessioni incentrate sull’Italia, condotte da artist* razzializzat* impegnat* a raccontare le proprie pratiche in una critica trasversale al sistema dell’arte e della cultura.
Oltre quindici ospiti si sono alternat* tra performance, talk e panel in una modalità ibrida on/offline. Al cuore dell’iniziativa la necessità di trasmettere riflessioni e pratiche pedagogiche generative di spazi, immaginari e rivendicazioni, in un dialogo transcontinentale «Italia/Usa» attento al contempo a valorizzare e provincializzare l’esperienza statunitense afroamericana.
La scuola è stata voluta dall’attuale direttrice del Mudec, Marina Pugliese, in dialogo con la mostra temporanea Rainbow allestita nel Museo e curata da Katya Inozemtseva. Rainbow riprende The Rainbow Show, una mostra curata nel 1975 al De Young Museum di San Francisco da Graham Lanier (uno degli speaker della scuola) ispirata al pensiero dell’attivista e teorica statunitense Angela Davis. La ricerca sulle espressioni artistiche e culturali dell’arcobaleno è ispirata all’idea della Rainbow Nation, una nazione/coalizione arcobaleno capace di ricucire assieme le differenze in una «coscienza politica e artistica spettrale».
Nell’incontro tra artist*, attivist* ed educator* sparsi al di qua e al di là dell’Atlantico sono emersi numerosi elementi di continuità così come specificità legate alle differenti storie di oppressione. Ma l’elemento che forse costituisce il ponte più evidente tra l’esperienza statunitense del Black Arts Movement e quella italiana di oggi è la dimensione della colonialità, ovvero la lettura della propria condizione come soggett* colonizzat* dentro e oltre i confini fisici dello stato nazione. È proprio uno dei maggiori esponenti del Black Arts Movement, il poeta, drammaturgo e critico Amiri Baraka, a parlare della dicotomia oppressore/colonizzatore e oppresso/colonizzato. Ed è questo modo di intendere il potere, più che una fedeltà alla linea del colore e alle sue espressioni identitarie, ad aprire alla possibilità di una coalizione arcobaleno. In questo senso, una particolare attenzione durante la settimana è stata data agli scambi e alleanze tra Ner* e Asiatic*. Il dialogo, facilitato da Ekalan Hou, ha visto Bob Lee e Eleanor Yung addentrarsi nel racconto di come il movimento Nero abbia influenzato le pratiche artistiche di solidarietà e di costruzione di comunità della minoranza APA (Asian Pacific American). L’idea di un internazionalismo Nero, capace di diventare una bandiera arcobaleno entro cui diverse esperienze di razzializzazione e oppressione possono essere ricomprese in una coalizione politica, ha un portato trasformativo ad oggi non sufficientemente compreso o valorizzato. Le possibilità insite in questo potenziale inesplorato sono ancor più evidenti se pensiamo al contesto italiano, in cui le persone portatrici di una storia subalterna appartengono a diaspore frammentate tra loro e al loro stesso interno.
L* artist* e l* teorich* chiamat* a partecipare hanno riallacciato vicende, influenze, e processi che caratterizzano l’incontro tra arte e teoria critica politica tra – e oltre – Italia e Stati Uniti. I teorici Fred Moten e Stefano Harney hanno parlato della relazione tra Black Power e operaismo italiano, la poetessa Wissal Houbabi ha messo al centro il ruolo del rap e della cultura hip hop quali strumenti di emancipazione subalterna in Italia, il polistrumentista Dudu Kouaté ha messo in scena una performance afrofuturista capace di triangolare e riattivare storie che uniscono Dakar a Milano e Chicago. La performer Luna de Rosa ha chiuso la settimana con un lavoro che pone al centro la voce di poetesse Rom e la loro resistenza alla deumanizzazione e “mostrizzazione” – elemento che caratterizza la costituzione di un gruppo come “razza”. E nella sala riecheggiava il pensiero di Cedric Robinson, che in Black Marxism (1983) racconta di come le popolazioni Rom siano state un «tavolo di prova», una sorta di «laboratorio interno», vittime della stessa violenza esercitata in un secondo momento verso gruppi colonizzati fuori dall’Europa.
Quello dell’arte e della produzione culturale è uno spazio di contesa estremamente carico, perché è il terreno di scontro tra violenza epistemica e resistenza epistemica. Per violenza epistemica, con la scuola postcoloniale, si intendono tutte le forme di violenza agite con e attraverso la conoscenza. Quest’espressione del potere coloniale è stata ed è tuttora essenziale nella riproduzione delle gerarchie razziali. Non è un caso se a livello globale, dal Sud Africa agli Stati Uniti all’Europa, l’azione dei movimenti antirazzisti si è concentrata sul patrimonio coloniale urbano. Strade, statue, istituzioni e premi, affermano, in uno spazio pubblico, un sistema di valori e di costruzione identitaria basato sulla supremazia etno/nazionale/razziale del gruppo dominante. È un processo di memorializzazione che prescinde dagli esiti delle storie evocate – si pensi solo alle statue confederate nel sud degli Stati Uniti, o i riferimenti nella toponomastica italiana alla battaglia di Adua – proprio perché queste storie non raccontano sé stesse, quanto piuttosto in chi ci si deve identificare, di chi si sta raccontando la storia. La violenza epistemica si consuma così, offrendo come unica prospettiva sul mondo, l’episteme, la conoscenza che si vuole universale, del gruppo dominante.
Quello coloniale è un archivio materiale e immateriale in continua produzione. Il luogo stesso in cui la scuola è stata ospitata è espressione di questo archivio. Il Mudec, infatti, è un museo etnografico che ospita reperti coloniali, e in questo senso è un luogo tutt’altro che neutro. Mistura Allison, ricercatrice, curatrice e film-maker, a partire da una critica sulle pratiche curatoriali e sull’atto stesso del display, ha invitato l* partecipanti a interrogarsi su cosa significhi custodire un “patrimonio condiviso” (shared heritage), e se questo sia possibile nell’asimmetria che caratterizza le relazioni di sapere/potere tra colonizzatore e colonizzat*. Queste critiche hanno avuto modo di essere esplorate in un dialogo tra il Museo e l* partecipanti della scuola attraverso due visite guidate, una alla mostra permanente e una ai depositi. Durante le visite abbiamo condiviso la storia delle collezioni, una storia che esplicita questa asimmetria di potere e che costruisce come «altr*» l* stess* artefici del patrimonio lì custodito.
Il rapporto tra cultura dominante e culture dominate e il modo in cui le culture dominate possono costruire spazi autonomi di senso e trasmissione delle conoscenze è stato uno dei cardini dei dibattiti sviluppati durante la settimana. Justin Thompson, co-fondatore di Black History Month Florence e di The Recovery Plan a Firenze, ha riportato alla necessità di immaginare luoghi nei quali sia possibile fare arte e cultura da, e per, la comunità afrodiscendente, affrancandosi dall’industria culturale bianca. Attraversare spazi culturali che sono il riflesso della cultura dominante implica sempre un doppio sforzo, perché all’espressione generativa di mondi possibili deve sempre precedere una decostruzione dell’esistente. E in questo senso la fatica non è indirizzata alla cura del sé e della coalizione – termine che è stato preferito a comunità – ma alla trasformazione della struttura di dominio che prescrive a una posizione subalterna. Numerose sono state le esperienze di autoorganizzazione evocate, sperimentazioni che hanno mostrato come l’autodeterminazione nella narrazione e nella produzione culturale e sociale sia possibile e necessaria. Allo stesso tempo è stato importante ricordare che sottrarsi interamente ad una relazione con le istituzioni impedisce la messa in atto di quelle micro-strategie che rappresentano forme – situate ma spesso riproducibili – di riparazione. Una riparazione materiale ancor prima che simbolica, perché sono proprio queste istituzioni, che hanno costituito e portato avanti un’idea di disuguaglianza e gerarchia razziale, ad essere in possesso di quelle risorse che debbono essere oggi ridistribuite sull* eredi di queste storie di subalternità.
Questa settimana di studi ha permesso che prendessero corpo alcuni dibattiti imprescindibili a livello teorico, critico, artistico, ma soprattutto politico. L’ordine coloniale è (da) sempre (e sempre) più evidente nelle società che abitiamo. Quest’ordine presiede le istituzioni politiche e culturali: una struttura razzista che ospita un sistema razzista. Mettere mano nell’archivio coloniale, riflettere sul senso di un’inter-coalizzazione, complottare un’eredità condivisa subalterna transcontinentale è essenziale per prosperare dentro, contro e oltre queste istituzioni e questo sistema.
Mackda Ghebremariam Tesfau'
Mackda Ghebremariam Tesfau’ è ricercatrice, docente precaria e attivista antirazzista. I suoi interessi di ricerca includono le teorie post e decoloniali, gli studi critici su razza e capitalismo razziale. Mackda e co-curatrice della Agitu Ideo Gudeta Fellowship, una forma di affirmative action pensata in collaborazione da Centrale Fies, Razzismo Brutta Storia e Black History Month Florence.
