POTLATCH
di Matteo Meschiari
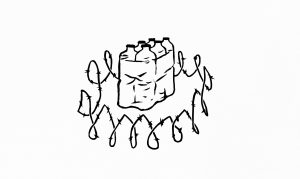
Nel coro del cimitero degli elefanti i topi sono parentesi quadre.
La fermammo con tre pietre sopra il cofano dell’automobile, due in alto negli angoli e una in basso al centro. In questo modo i lembi inferiori, come i cran di una giacca alzati dal vento, minacciavano di portare con sé una catastrofe tettonica di terre pastello. Invece, inspiegabilmente, restavano lì, oscillanti, elastici, lasciandoci volare indisturbati con occhi-uccello sopra il punto della mappa che, poco meno tre anni prima, un vagabondo venuto dalle montagne aveva cerchiato di rosso.
«Sarebbe questo» disse Clo.
«Mm» dissi fingendomi attento.
Clo stava seguendo con il dito sottile e l’unghia nera di morchia una pista che in altri anni era stata la E 80 nel tratto italiano transappenninico. Mi aspettavo che il grasso di macchina su quel dito lasciasse un nembostrato sulla mappa, ma non lo fece, forse perché il suo corpo, masticato e asciugato dal tempo e dalle uscite nel bush, aveva mantenuto una qualche leggerezza del prima. Clo era stata una ragazza e poi una donna dalle ossa tanto sottili che la falce biologica avrebbe dovuto mieterla subito, quando le strisciate sonore delle ambulanze e poi dei caccia turchi avevano fasciato la Capitale e i quattro quinti della popolazione urbana era scomparsa nel pozzo della notte. Invece era lì davanti a me, pronta a seppellirmi con uno sguardo e un fiore di landa sul bordo di una pista qualunque.
«Siamo sicuri che ci siano ancora? Che siano rimasti lì?»
«Non lo so» risposi. L’uso precatastrofe del congiuntivo mi sorprendeva sempre.
«Se sono rimasti lì credi che ci accoglieranno?»
«È possibile».
Clo mi guardò con quegli occhi neri, infossati, come di uccello messo in gabbia, certa di farmi capire per l’ennesima volta che era stata indulgente. Lo faceva da venticinque anni, sempre allo stesso modo, con un sorriso in bilico tra compassione e desiderio di annientamento. Mi sentii in dovere di tenderle un rametto per aggrapparsi.
«Possiamo andare a vedere – dissi – faremo attenzione».
Clo era tornata dentro la mappa. Trasferitasi nella punta del suo dito percorreva una zona verde, che oggi non è più verde, adeguandosi al terreno e rallentando dove le curve di livello si avvicinavano tra loro, come a ripetere la fatica della pendenza.
«La macchina può farcela – disse – ma poi dovremo lasciarla qui, e proseguire a piedi».
La punta del dito si era fermata su qualcosa di grande quanto una squama di pesce. Poteva essere uno spiazzo, una spianata, qualcosa di lasciato a sé stesso dopo un cantiere smantellato, una parcella di terreno destinata a uno sviluppo industriale che non era arrivato mai. Io annuii, Clo non mi vide. Tolse le pietre, lasciò che la carta topografica si riavvolgesse con uno schiocco, salì al volante.
Le montagne si spostavano a destra e a sinistra con le curve della strada mentre ai lati c’era una zona rurale abbandonata che colava contro la macchina come vernice fresca. Lo chassis rinforzato era così pesante che un cavallo al galoppo ci avrebbe superati con il sorriso sulle natiche, ma tutti i cavalli erano stati mangiati durante il primo decennio e noi, su quella macchina, eravamo l’unica cosa in movimento tra Tivoli e Torano, fatta eccezione ovviamente per gli insetti.
L’Appennino oscillava davanti a quel tratto di E 80 con i colori della sabbia e della cenere. Non conoscevo quella parte della catena ma prima del salto climatico l’avevo sempre immaginata uguale a sé stessa, come il dorso multiplo di un antico ramarro cosmico, nutrito a foglie di faggio e muschio e abetine odorose. Adesso che tutto era un bush perennemente ingiallito dalle tempeste di polvere, visto da lontano, decifrato attraverso gli spessori di cellophane dell’aria calda, ridotto a linee essenziali, geologizzato dal collasso, mi riaccendeva nella memoria degli schedari fotografici alieni, qualcosa della Mongolia, le rioliti islandesi, il New Messico, e invece era solo un laggiù postappenninico traforato dai grandi nidi delle zecche.
«La facevo sempre» disse Clo.
«Per andare in Abruzzo?»
«Aha».
«Me lo racconti?»
«No».
«Non vuoi nemmeno raccontarmi della gricia di nonna e delle lunghe passeggiate nei boschi con i tuoi amori di un tempo che fu?»
Lo dissi con una voce stupida che la fece quasi ridere, mentre il fuori ci riassorbiva come una macchina arrancante dentro un deserto vuoto di persone che raggrumava in dovere i fantasmi della sopravvivenza.
«Per te saranno là?»
«Davvero Clo, non lo so».
«Mat, stiamo facendo la cosa giusta?»
«No Clo».
Lei mi lanciò il secondo tipo di occhiata che aveva disegnato per me, questa volta a partire dal crollo. Diceva non farmi questo, non farlo ti prego, proprio adesso no, non farlo.
«Secondo me – dissi – quei fanatici non ci sono più. Sono finiti. E se ci sono ci stiamo andando per un sentito dire. Un vagabondo fa un cerchio rosso sulla tua mappa e tu decidi di partire. Ci lavori due anni, raccogli la merce in cinque valige, ci metti sei mesi a riempire il serbatoio, e mi chiedi di accompagnarti in un viaggio che forse sarà la scena finale per i nostri corpi e per i ricordi che portiamo con noi. No Clo, non stiamo facendo la cosa giusta. Neanche un po’».
«Immagina se invece ci sono, se prenderanno la merce e ci daranno in cambio delle cose che ci servono. Magari hanno del repellente buono, che ne so. Magari hanno adrenalina, autoiniettori di antidoto che ancora funziona, antistaminici. Abbiamo ventiquattro orfani a Primavalle. Magari qualcuno diventerà adulto grazie a questa cosa tanto sbagliata che stanno facendo due vecchi del vecchio mondo in un mondo senza più vecchi. Pensaci, amore mio».
«Sì. Ci penserò».
Le montagne erano più vicine. Adesso che l’aria del pomeriggio era meno calda e meno torbida si vedevano le frane sui versanti e i fantasmi circolari sul terreno delle colonie di zecche.
«Mettiamo le tute?» chiesi.
«Siamo ancora lontani. La stagione ci aiuta. Dormiamo un po’ più avanti e le mettiamo domattina. Il rischio è tollerabile».
Ci fermammo in una stazione di servizio che non era sulla strada principale e che si era salvata dai saccheggi dei primi giorni.
«Ci fermavamo qui, quando ero bambina, piaceva a mio papà».
Non trovammo carburante ma era un posto tranquillo, adatto per la notte. La porta a vetri del negozio era chiusa bene e le zecche non erano entrate mai. Qualcuno aveva chiuso tutto sperando di ritornarci un giorno e il posto era come sigillato, uno spettro di spazio in un tempo estroflesso destinato a nessuno. Oppure destinato a noi. Clo riuscì ad aprire il lucchetto, sciolse la catena che girava due volte attorno alle maniglie di alluminio ed entrammo. Il cibo era polvere o crosta o melma torva, le pile avevano vomitato tutto l’acido che avevano in corpo, le catene da neve erano feticci polinesiani.
«Guarda» disse Clo.
Raccolse da terra un libro caduto dal grosso contenitore di plaxiglass, una semisfera trasparente dove nei giorni del funzionamento erano stati gettati libri come barattoli tra i barattoli.
«Non è il genere di roba che avrei detto di poter trovare in una stazione di servizio» dissi, provando subito a disinteressarmene. Ma Clo insistette.
«Catullo» disse, abbassando inconsapevolmente la voce, gli occhi d’uccello che brillavano.
«Lascia – dissi – rimettilo nel Graal di plastica delle mille cose perdute per sempre e concentrati sull’adesso-qui, ad esempio su che cosa abbiamo portato da mangiare».
«Non sei credibile – disse lei – ci tieni più di me».
«Ci tenevo, amore mio. Adesso tengo a non farmi pungere, a riempirmi la pancia quel tanto da ricordare allo stomaco che esiste davvero, e magari tengo a qualche testa rasata dei nostri orfani. Marchino, ad esempio, mi piace molto».
Clo sfogliava le pagine e leggeva verpa e basia come varianti dello stesso discorso, un anfibio uscito dal brodo archeano poi coperto di peli nel pleistocene culturale ma, alla fine, un’unica lingua binaria di gameti specie-specifici.
«Mangiamo?» la incalzai.
Clo lasciò cadere il libro nel contenitore tra tutti gli altri libri scontati dal 50 al 70%.
«Ti rendi conto? – disse – Questo te lo portavi a casa per 2 euro e 90».
«Pensa che roba scarsa, allora».
«Sì. Oppure no. Però è strano se ci pensi».
«Cosa strano?»
«Il prezzo. I soldi. Lo spreco».
«Senti. Qui ho le gallette integrali. Cicoria in polvere. Acqua che possiamo scaldare. Un po’ di crema di agave. Non ho la Guinness, ma quella non è mai esistita, giusto?»
Dormimmo per qualche ora. La notte era senza stelle. Poi l’alba. Indossammo le protezioni e ripartimmo.
Guardai Clo uscire dalla porta davanti a me in quella tuta troppo grande. Era tutta arancione per il colore del sole nascente.
«Arrivo» dissi. Tornai al contenitore di plexiglass e la raggiunsi. Lei era già seduta in macchina con le mani sui fili scoperti dell’accensione. Mi guardava con un senso di urgenza attraverso la visiera trasparente e, nel riflesso della plastica che raccoglieva pezzi di mondo, nell’arancione dell’incendio globale, sembrava ancora giovane, ancora mia.
La macchina passò con lentezza un agglomerato di via, abitato da lucertole che in un’altra occasione ci saremmo fermati a cacciare.
«Saranno due chili, forse tre» dissi.
«Lucertole di Amatrice» disse Clo, pensando a cose di un allora che non conoscevo.
Mi ero voltato a guardarla e così non mi accorsi della macchina di traverso sulla strada. Clo frenò, la nostra auto pattinò sulle tre dita di polvere per qualche metro e infine andò a sbattere contro la portiera della Yaris.
Scendemmo e notammo subito qualcosa di insolito.
«Hai visto le strisciate?»
«Sì. È stata spostata. L’hanno tirata apposta».
Un suono di aria forata. Mi volto verso la finestra. Poi mi volto verso Clo che si appoggia con la mano sinistra alla macchina. Una freccia le trapassa il fianco all’altezza del pancreas. Lo stomaco mi sale in testa. La aiuto a cadere e aspetto il mio turno. Ma il mio turno non arriva. Dalla casa della finestra escono due persone e altre due arrivano dal fondo della via. Immagino che ce ne siano altre ancora dietro di noi. Mi basta il rumore dei passi ma non ho voglia di voltarmi a guardare.
«Siete in terra occupata» dice una donna sulla trentina, vestita di plastica, la faccia scoperta.
«Stavamo solo passando» dissi io.
«Non di qui, non da noi» disse lei.
«Ma non abbiamo niente che vi serve» provai.
Qualcuno stava già aprendo le portiere e tirando fuori le cinque valigie.
«Non credo che vi interessi» dissi.
La donna mi ignorò e andò a vedere. Aprì le valige e sembrò sorpresa. Prese una mazzetta da pezzi da 200 euro intonsi, ancora tenuti assieme dalla fascetta dell’Istituto Poligrafico. Le valige erano piene di migliaia di banconote nuove, rosa, verdi, gialle, viola, soprattutto blu. La donna le prendeva in mano mazzetta dopo mazzetta e le faceva frusciare sotto il pollice come un libro animato. Le guardava, le annusava, scuoteva la testa. Poi si alzò e venne da noi, stando attenta a non pestare la piccola pozza di sangue.
«Che cosa ci volevate fare?» chiese.
«Volevamo barattarli».
«Con chi?»
«Gente dalle parti di Corvaro».
«I Gatti?»
«Non lo so come si chiamano. Ci hanno detto che cercavano soldi».
La donna rise poco convinta.
«Un vagabondo ci ha detto che da quelle parti vogliono i soldi – continuai – che sono pronti a barattarli. Medicine. Antidoti. Antistaminici».
«E voi siete venuti qui per barattare soldi».
«Non lo so. Vogliono usarli per qualcosa, ci hanno detto, non sappiamo che cosa, non ci interessa».
La donna fece un segno con il mento a qualcuno alle nostre spalle. Io chiusi gli occhi aspettando il colpo ma il colpo non arrivò. La donna andò via, la gente con lei se ne andò, e noi restammo lì con la macchina. Avevano preso le valige.
Con un milione e mezzo di micromanovre feci inversione e ripresi lentamente la E 80 in direzione Roma. L’Appennino era alle nostre spalle come un mostro di sabbia. Uno stomaco gonfio di zecche che avrebbero risucchiato l’umanità in sé stesse e che io immaginavo risalirmi lungo la schiena dalla fessura nel sedile. Oppure ero io le zecche, e la mia schiena era la strada. Davanti c’erano le nebbie dell’evaporazione marina, le tempeste elettriche. Ai lati le stesse cose che all’andata ma rovesciate come in un loop. Il tempo a disposizione era solo uno, però, e adesso tornare indietro era questione di geografia, non di storia. Solo geografia. A un certo punto mi fermai per aiutare Clo a togliersi la tuta. Non sanguinava molto ma non mi attentavo a togliere la freccia.
«Non so come fermare l’emorragia» dissi.
«Lo so, dobbiamo provare a tornare a casa» disse lei.
«Vuoi leggere?» chiesi, e le diedi il libro di Catullo che avevo in una tasca sulla gamba.
«No – disse lei – raccontami qualcosa».
Mi grattai il naso come se fosse di qualcun altro.
«Il Potlatch era una cerimonia rituale che si svolgeva presso alcuni gruppi di Nativi Americani sulla costa nord-ovest del Pacifico, tra Stati Uniti e Canada. Erano gli Haida, i Salish, i Nuu-chah-nulth, i Tlingit, i Kwakiutl. Consisteva in un banchetto a base di foca o salmone in cui la ricchezza di un individuo e della sua famiglia veniva ostentata distruggendo dei beni preziosi. Più distruggevi e più il tuo prestigio era grande. La cosa serviva a confermare o rovesciare rapporti di potere, dilapidando sostanze eccessive che, se immesse in circolo nella tribù, avrebbero alterato gli equilibri sociali. Una specie di comunismo sacrificale, una valvola per alleviare la disparità economica, una…».
Matteo Meschiari
Matteo Meschiari (1968) è antropologo, geografo e scrittore. Si occupa di preistoria, paesaggio, letteratura e dinamiche culturali dell’Antropocene. Ha pubblicato vari libri di saggistica, narrativa e poesia.
