Venezia, la peste, il teatro
di Leonardo Mello
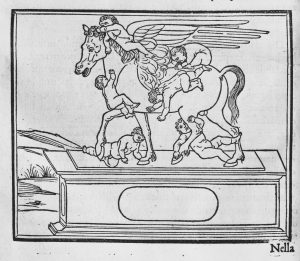
«Il teatro deve essere come la peste, la cui virulenza sconvolge l’ordine dato e dissolve l’organismo che attacca, ma lo dissolve nel cervello e nei polmoni, quegli organi che sono alla diretta dipendenza della coscienza e della volontà, è lì che la peste attacca. E l’appestato muore senza distruzione materiale, muore di male assoluto e astratto, come l’attore, penetrato e sconvolto dai sentimenti. Nel fisico dell’attore come in quello dell’appestato, la vita ha reagito fino al parossismo ma non è avvenuto nulla. Teatro e peste sono un’identica epidemia, una combustione».
Citare Antonin Artaud ai tempi del coronavirus può sembrare scontato, ma rimane estremamente suggestiva la relazione tra teatro e peste, intesa, quest’ultima, come fonte liberatrice e liberatoria, in un contesto esclusivamente e squisitamente utopico.
Nella realtà quotidiana, invece, il contraccolpo di un’epidemia come quella attuale ha delle ricadute pesantissime sull’arte che più di tutte le altre concepisce la sua esistenza come fatto sociale: l’aggregazione è intrinsecamente caratteristica del teatro, perché, come è noto, anche dal punto di vista semiotico il teatro non può sussistere senza qualcuno che stia a osservare al di là del recinto in cui l’azione scenica si svolge. Dunque peste e teatro sono i due poli di un’antinomia strutturale che resta inalterata nonostante cambino le coordinate temporali e geografiche.
Per comprendere appieno le ingenti, insormontabili difficoltà in cui il sistema teatrale contemporaneo si trova oggi a operare (o meglio a non poter operare) ci soccorre un breve excursus storico. Ci trasferiamo ai tempi della Serenissima, nell’ultima fase del suo splendore, cioè nella prima metà del Seicento. Venezia, in realtà, aveva già cominciato il suo lento e inesorabile declino, la potenza marittima che l’aveva vista incontrastata padrona di un vasto e variegato impero stava dando i primi segni della sua caduta, la scoperta delle Americhe aveva già drasticamente mutato flussi e rotte di navigazione, e la Repubblica marinara cercava – senza successo – di espandersi via terra. Tuttavia, nella vita pubblica, questi segnali di decadimento non erano affatto avvertiti. Anzi, proprio in quel periodo si può dire che la città fosse il centro (o quantomeno uno dei centri) della produzione culturale europea. E particolarmente per quanto riguarda il teatro.
Se già nel XVI secolo le manifestazioni sceniche avevano cominciato – caso unico in Italia – a perdere il loro carattere spontaneistico, legato alla ricreazione e allo svago di nobili appassionati, rivelandosi come fenomeno di rilevanza pubblica, attraverso la costruzione di luoghi effimeri adibiti alle rappresentazioni, è nel secolo successivo che Venezia vede la fioritura di almeno sedici strutture stabili, riconosciute dalle autorità e definitivamente dedicate alle messinscene. A questa metamorfosi, che prelude al sistema teatrale occidentale in vigore ancora oggi, contribuiscono diversi fattori. Riassumendo in estrema sintesi, determinanti furono gli interessi economici di una manciata di illustri casate (i Grimani, i Tron, i Vendramin…) che pensarono – quasi sempre a torto – di poter trarre profitto dall’apertura delle sale teatrali. Venne ingaggiata una vera e propria lotta tra famiglie nobiliari, che all’effettivo introito ottenuto dal noleggio dei palchi univano anche l’esigenza di sempre maggior prestigio e visibilità, elementi necessari a controllare anche altri e ben più strategici settori della vita politica della Repubblica. Proprio grazie alla peculiarità di quest’organizzazione sociale, Venezia divenne in breve tempo la patria del melodramma, in una ‘fabbrica’ continua di nuove fantasmagorie sceniche che incantava gli spettatori di tutto il mondo. Sull’altro versante pari successo conquistò la prosa, nelle trasposizioni della commedia dell’arte che da lì a poco daranno vita alla celebre riforma goldoniana (e alla ‘controriforma’ aristocratica e conservatrice del principale antagonista dell’Avvocato, Carlo Gozzi).
In un panorama così felicemente connotato dalla ricchezza di proposte teatrali si insinua però periodicamente un’ospite indesiderata come la peste. Se quella del 1575 – che aveva spinto la città a erigere la Chiesa del Redentore, nell’isola della Giudecca – intaccava ancora di striscio le strutture già in attività, ben diverso è lo scenario cui si assiste solo sessant’anni dopo, quando il morbo ritorna più virulento che mai a invadere la città d’acqua. Il 1630 è un anno funesto, in cui il blocco di ogni attività è adottato con estremo rigore da una magistratura appositamente istituita già dal 1485, i Provveditori alla Sanità. Questi funzionari avevano una discrezionalità quasi assoluta, e si avvalevano di metodi quasi ‘polizieschi’. Sin da quella data le misure adottate erano stringenti e puntuali: «Appena scoppiava il morbo – scrive Pompeo Molmenti – erano eletti nei sestieri e nelle parrocchie appositi delegati per vigilare sulla pulizia delle case, per vietare la vendita dei cibi nocivi, per far chiudere scuole, taverne e teatri e proibire le prediche e le funzioni nelle chiese. Si impediva qualunque comunicazione e commercio tra le varie contrade della città, non potendo alcuno che abitasse in una contrada passar nell’altra». La chiusura, insomma, era totale e senza alcuna possibilità di deroga. Ma i Provveditori operavano anche altre drastiche limitazioni della libertà individuale. Come nota Willy Burguet, oltre a vietare, come si è visto, «le riunioni pubbliche, le fiere, gli spettacoli, limitano i movimenti della gente e proibiscono l’immigrazione» da zone quali la Dalmazia e l’Albania.
L’epidemia del 1630 viene portata a Venezia dall’ambasciatore del ducato di Mantova, che – confinato in quarantena (termine che proprio la Serenissima ha coniato per casi simili) nell’isola di San Clemente – trasmette il contagio attraverso il falegname chiamato a predisporre un’abitazione degna del suo rango. Racconta Giuseppe Tassini: «Una terribile pestilenza fu quella del 1630. Fu portata in città da Giovanni Maria Tirinello, un falegname che abitava dietro il campanile, in campo Sant’Agnese. Aveva contratto il morbo nell’isola di San Clemente, dove si era recato a lavorare: in quell’isola erano appena morti il marchese di Strigis, ambasciatore del duca di Mantova e cinque suoi servitori che provenivano dai luoghi infetti dell’esercito. Questa peste fu una delle più tremende: comparve a luglio e terminò nel novembre del 1631. Uccise ottantamila persone in città e seicentomila in terraferma. La prima guarigione, considerata miracolosa, avvenne a San Polo e così i veneziani decisero di andare in Pellegrinaggio in Chiesa di San Polo finché non fu costruita la Chiesa della Madonna della Salute, consacrata il 9 novembre 1687».
La reazione delle autorità non è questa volta delle più repentine, e quando tutti gli accorgimenti necessari vengono introdotti è ormai troppo tardi. Le cifre parlano di 44.560 morti, su un totale di circa 140.000 abitanti, dato che aumenta però esponenzialmente se si aggiungono i decessi delle isole adiacenti. La città, visto anche l’alto indice demografico, era una vera e propria metropoli (a quei tempi veniva considerata città un agglomerato di almeno 10.000 abitanti), e le ricadute sulla vita sociale, piuttosto vivace, sono durissime: la gente, abituata a vivere per strada di giorno e di notte, viene stravolta nelle sue più radicate abitudini.
Per rendersi conto di quale fosse la quotidianità di Venezia ricorriamo ancora a Molmenti: «La vita e il movimento erano in piena animazione al suono della campana di terza, circa alle otto di estate, alle dieci d’inverno. L’orario comune dei pubblici uffici era fissato dall’ora di terza all’una dopo mezzogiorno. […] Al tramonto del sole, la campana realtina di San Giovanni di Rialto annunziava agli operai la fine del lavoro; i negozi di commerci si chiudevano alle nove di sera; dopo mezzanotte le botteghe dei commestibili e quelle osterie che non avevano licenza di restare aperta tutta la notte. […] Non meno singolare la vita delle strade durante la notte. Scarsa l’illuminazione, tranne che a San Marco e a Rialto. […] Certe calli erano rischiarate appena da un lanternino, […] che ardeva dinanzi alle immagini sacre. Per condurre, a traverso il buio notturno, chi potea pagarsi queste comodità, stavano in luoghi determinati uomini conosciuti, fidati, spesso fin troppo compiacenti, con un fanalino in mano. […] Oltre le feste all’aria aperta, altri svaghi offrivano ai veneziani i luoghi di ritrovo: i teatri, i casini, i caffè, le osterie. Fin dal Seicento uno straniero scriveva: “Ove più si contrassegna Venezia fra tutte le città d’Italia è nella magnificenza e nell’eleganza dei teatri”».
È abbastanza facile immaginarsi quanto scompiglio e disappunto abbiano causato le restrizioni dovute alla peste, e quali conseguenze negative abbiano comportato per i nobili cittadini che avevano deciso di lasciarsi tentare dall’avventura teatrale. In particolare alcune sale, già da tempo attive, furono costrette a chiudere i battenti, con evidenti, drammatiche ricadute sul piano economico. Tra queste ricordiamo almeno il Teatro di San Cassiano, patria della commedia e dominio incontrastato, sin dall’inizio del secolo, di un attore celeberrimo e osannato come Francesco Gabrielli, alias Scapino. Perduto in uno dei frequenti incendi nel 1629, dovette aspettare la fine della peste per riaprire rinnovato tra il ’34 e il ’36.
Normalmente, che andassero a fuoco o meno, i teatri venivano ricostruiti in pochi mesi in forma sempre nuova per rispondere alle esigenti aspettative degli spettatori. Ne è un esempio il Teatro di San Moisè, proprietà della famiglia Zane, che proprio nel ’29 subisce un radicale lavoro di riedificazione per poi restare chiuso nella stagione successiva. (Nicola Mangini spiega quali fossero i momenti dell’anno dedicati alle rappresentazioni: «In autunno si aprivano i teatri di commedia, mentre – per lo più in novembre – si iniziavano le prove delle opere in musica. […] I teatri musicali principiavano gli spettacoli subito dopo Natale, il giorno di Santo Stefano, e restavano aperti per tutto il carnevale, come pure i teatri di commedia. Poi le sale chiudevano, e i veneziani si concedevano altri trattenimenti»). Chiusura obbligata, poi, anche per uno dei più importanti spazi scenici veneziani, il Teatro San Luca, gestito dalla potente casata Vendramin, dove più tardi Goldoni raggiungerà l’apice della carriera e della notorietà. Qui nel 1629 si era trasferito dal San Cassiano il citato Scapino Gabrielli, che proprio nella quaresima dell’anno seguente recita con una compagnia «rappezzata da principio», a pochi mesi dal divieto assoluto di ogni forma di spettacolo, sia al chiuso che all’aperto.
Il contagio e l’epidemia bloccano quindi del tutto il fermento teatrale della città. Ma forse, in conclusione, si può intravedere anche un aspetto positivo. La peste diviene un po’ uno spartiacque tra la prima e la seconda metà del secolo: probabilmente anche grazie alla forzata inattività dovuta all’epidemia, la voglia di teatro diviene ancora più forte, così come si espande, per dirla in termini economici, la domanda. Infatti, negli anni subito successivi nuovissime sale vedranno la luce, schierando in prima linea la famiglia che più di ogni altra si dedicherà all’intrattenimento spettacolare tra Sei e Settecento, cioè gli influentissimi Grimani. Il melodramma esploderà tra gli anni Quaranta e Cinquanta, mentre parallelamente si affineranno le armi della commedia, e Venezia diverrà un unicum nella storia del teatro occidentale. Bei tempi!
————————
Bibliografia essenziale:
Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 2000.
Carmelo Alberti, L’invenzione del teatro, Biblioteca digitale Treccani, 1997.
Willy Burguet, Venezia e la peste: lazzaretti e immagini, Conferenza per il comitato di Liegi della società Dante Alighieri, 2012.
Leonardo Mello, Il Settecento veneziano. Il teatro comico, Corbo e Fiore Editori, Venezia 2013.
Pompeo Molmenti, La società di Venezia nella vita privata, Lint, Trieste 1981.
Nicola Mangini, I teatri di Venezia, Mursia, Milano 1974.
Giuseppe Tassini, Curiosità veneziane, Filippi Editore, Venezia 2009.
Giuseppe Tassini, Feste e spettacoli. Divertimenti e piaceri degli antichi veneziani, Filippi Editore, Venezia 2009.
Nelli Vanzan Marchini, La peste del 1630 a Venezia e la Madonna della Salute, timermagazine.press, 2019.
Leonardo Mello
Leonardo Mello è uno studioso e critico teatrale. Nel 1997, mentre frequenta la Scuola di Specializzazione in Comunicazioni Sociali dell’Università Cattolica di Milano, inizia a lavorare come redattore presso Ubulibri – Le edizioni dello spettacolo di Franco Quadri. Nel 1999 diviene caporedattore della medesima casa editrice, curando una serie di pubblicazioni, e fino al 2002 è direttore esecutivo del Patalogo. Annuario dello spettacolo, con il quale continua a collaborare fino al 2009. Particolarmente interessato alla nuova drammaturgia, è preselezionatore del Premio Riccione per il Teatro dal 2001 al 2007. Dal 2003 al 2013 insegna Storia del teatro e della drammaturgia all’Università Cattolica di Brescia (dove in seguito, e fino all’anno corrente, cura il workshop di critica teatrale). Nel 2004 fonda e dirige la rivista di teatro e spettacolo «VeneziaMusica e dintorni», edita dalla Fondazione di Venezia. Dal 2013 il periodico entra a far parte delle attività editoriali del Teatro La Fenice di Venezia. Tra i volumi più recenti, si citano almeno Antonio Tarantino, Gramsci a Turi e altri testi, Ubulibri, Milano 2009 (a cura di), Teatro Laboratorio della Toscana diretto da Federico Tiezzi, Titivillus, Pisa 2013 (a cura di), Il Settecento veneziano. Il teatro comico, Corbo e Fiore, Venezia 2013, Ronconi secondo Quadri, Roma, Ubulibri 2016 (a cura di), Tiezzi secondo Quadri, Ubulibri, Roma 2017 (a cura di), Heike Cantori Wallbaum, L’euritmia una danza non danza, Titivillus, Pisa 2019 (a cura di).
